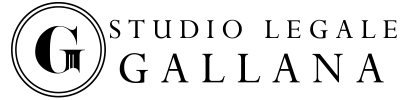Separazione dei Beni
L’art. 516 c.c. che disciplina il termine trimestrale per l’esercizio del diritto alla separazione ereditaria, assurge a questione manifestamente fondata di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 della Carta suprema?
Posto che il termine di tre mesi per l’esercizio del diritto di separazione dei beni ereditari è stabilito a pena di decadenza, è manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 516 c.c., in riferimento: a) all’art. 3 Cost., nella parte in cui attua una disparità di trattamento tra gli eredi del defunto e i creditori o i legatari del de cuius, in base all’assunto che i primi possano accettare l’eredità beneficiata in un termine estremamente maggiore rispetto ai secondi, poiché il principio di eguaglianza non può essere invocato mettendo a confronto situazioni giuridiche sostanzialmente diverse nei presupposti e nelle finalità; b) all’art. 24 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine per l’esercizio del diritto di separazione dall’apertura della successione e non dalla conoscenza della morte del “de cuius”, poiché l’incondizionato esercizio dei diritti non è intaccato dalla previsione di termini di decadenza (Cass. 3546/04).
Il caso concerneva la seguente vicenda: Tizio e i figli, Caio e Sempronio, venditori di un immobile in Roma che era loro pervenuto per successione, e Mevio, acquirente dell’immobile, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, Caietto, chiedendo che nei suoi confronti venisse dichiarata illegittima l’iscrizione della separazione dei beni ereditari compiuta da quest’ultimo. Caietto si costituiva in giudizio sostenendo che l’iscrizione fosse legittima sia perché fatta in conseguenza della vendita ereditaria sia perché il termine trimestrale per la separazione dei beni, da lui non rispettato, era ordinatorio e non decadenziale. Il convenuto proponeva altresì domanda riconvenzionale allo scopo di ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di compravendita e della divisione ereditaria. Accolta la domanda da parte del Tribunale di Roma, la Corte d’Appello, su gravame di Caietto, confermava la sentenza di primo grado. Caietto presentava quindi ricorso per cassazione.
Gli Ermellini affermavano in questa risalente -ma non per ciò meno interessante- sentenza che la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede (art.512 c.c.) sia istituto volto ad assicurare la soddisfazione dei creditori e dei legatari del de cuius, a preferenza dei creditori dell’erede; essa, infatti, persegue lo scopo di assicurare il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell’erede. Aggiungevano che il diritto alla separazione, per quanto concerne i beni immobili, dovesse essere esercitato attraverso l’iscrizione del credito o del legato all’ufficio delle ipoteche. Tale diritto doveva inoltre essere esercitato entro il termine di 3 mesi dall’apertura della successione (art. 516 c.c.).
Sulla base di tali caratteristiche, la Suprema Corte distingueva nettamente l’istituto della separazione ereditaria da quello dell’accettazione con beneficio d’inventario (art. 490 c.c.). Essi infatti si differenziano per quanto concerne la loro struttura sostanziale, dal momento che, mentre la separazione dei beni fa sorgere un diritto reale di garanzia a favore dei creditori del de cuius, l’accettazione con beneficio d’inventario produce come effetto quello di consentire all’erede beneficiato di non essere tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. Da ciò la Corte deduceva che, in riferimento alla previsione di cui all’art. 516 c.c., fosse manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art.3 Cost., dal momento che separazione dei beni e l’accettazione con beneficio d’inventario sono istituti diversi che richiedono presupposti diversi e mirano a differenti finalità.
La Cassazione, in tale sentenza, afferma per di più che il termine previsto all’art. 516 c.c. sia un termine perentorio e di decadenza, non ordinatorio. Ma la previsione di tale termine decadenziale non costituisce per ciò soltanto una violazione dell’art.24 Cost.